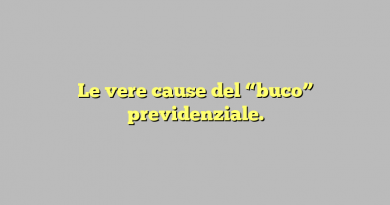GLI SVILUPPI DELLA CRISI E IL CONFLITTO
Le ragioni e le fonti della crisi
Se dovessimo prendere alla lettera le interpretazioni della crisi economica e finanziaria – esplosa negli Stati Uniti, in Europa e nel capitalismo occidentale sviluppato a partire dal 2008 – che vanno per la maggiore in certa sinistra “antagonista” italiana, si resterebbe sbalorditi per la loro faciloneria, inconsistenza e distanza dalla realtà: al punto che mi viene da dire che non si possa neanche parlare di vere analisi, quanto di un insieme di slogan politici, usati perché probabilmente ritenuti i più facili e accattivanti per incontrare un certo favore popolare, storicamente allertato contro le plutocrazie e il dominio del denaro e della grande finanza. Comunque sia, in gran parte dei giudizi sulla crisi che sono circolati negli ultimi tempi nei suddetti ambienti, salta immediatamente agli occhi un clamoroso scambio tra cause ed effetti: ad esempio l’espansione enorme del ricorso agli strumenti finanziari, nelle loro forme più velenose, e alla massima esposizione monetaria da parte degli Stati, invece di venir valutata per quel che è stata, cioè il tentativo estremo e avventuroso di sfuggire alla incombente crisi strutturale del capitalismo occidentale, viene considerata la fonte primaria della crisi stessa.
In genere, tale diffusa vulgata si fonda sui seguenti punti:
a) il capitale finanziario,improduttivo e parassitario, ha sostituito come principale fonte di profitto e di interesse per i capitalisti privati il capitale produttivo, industriale, agricolo e commerciale;
b) la finanza dominante non ha più connotati nazionali, ma è oramai una gigantesca piovra che, coordinata a livello globale con strumenti extraistituzionali, soffoca inesorabilmente la parte “sana” dell’economia dei paesi più forti, nonché di quelli subordinati, e detta legge agli Stati come alle popolazioni;
c) gli Stati, anche quelli più forti e potenti, non sono in grado di contrastare il dominio del capitale finanziario transnazionale e dunque non hanno più un vero ruolo dirigente, non riescono più ad amministrare neanche il capitale pubblico nazionale e devono rincorrere i diktat dei mercati e piegarsi ad essi;
d) conseguentemente, il potere della Politica è ridotto ai minimi termini anche negli Stati più rilevanti, la democrazia borghese e istituzionale è di fatto annullata e i partiti e i Parlamenti sono al puro servizio dei grandi gruppi finanziari multinazionali, delle banche e dei “mercati”;
e) in particolare in Europa a dirigere le danze sono la BCE (la Banca Centrale Europea, diretta da Draghi), il FMI (Fondo Monetario Internazionale) e la Commissione Europea, mentre i governanti, in particolare Monti per l’Italia, non costituirebbero altro che gli agenti del governo unico delle banche.
“Nell’Unione Europea la costruzione miope e autoritaria dell’euro e i patti di stabilità ad esso collegati, hanno prodotto una dittatura di banche e finanza che sta distruggendo ogni diritto sociale e civile. La democrazia viene cancellata da questa dittatura, perché tutti i governi, quale che sia la loro collocazione politica, devono obbedire ai suoi dettati…I politici, quelli italiani in particolare, privi di vero potere e coperti di piccoli e grandi privilegi di casta, pensano di proteggere se stessi, facendosi tutelare dalla dittatura bancaria…Il governo unico delle banche e della finanza che impone le sue misure a tutto il potere politico europeo non ha paura di noi…occorre fare uno sforzo per mettere insieme le nostre forze e per costruire un fronte comune, sociale e politico, che sia alternativo al governo unico delle banche”.
Piuttosto illuminante al proposito mi pare questo brano, tratto da un Appello (1) circolato nell’estate __________
(1) L’Appello è stato redatto con la convergenza di alcune strutture sindacali come la Rete 28 Aprile, corrente di minoranza della Fiom, e l’Unione Sindacale di Base, nonché di piccoli gruppi politici come la Rete dei Comunisti e Sinistra Critica.
scorsa, “Per un fronte comune contro il governo unico delle banche”, sulla cui base si è fondato un coordinamento politico-sindacale denominato No-Debito. Pur lasciando da parte quel ben singolare lamento sulla democrazia “cancellata da questa dittatura” – da cui deriverebbe, sorprendentemente, che gli autori del testo ritengono che i precedenti governi di Berlusconi o di Prodi garantissero la democrazia in Italia – , sul piano puramente analitico l’idea di un governo unico delle banche richiama precedenti improvvisazioni sul tema del super-imperialismo, cioè di una ipotetica unificazione mondiale del capitalismo (qui nella veste finanziaria dominante) con conseguente comando unico sui governi del pianeta: tesi non dissimili da quella di Negri, all’inizio del 2000, su un Impero unificato a guida USA che avrebbe posto fine ai conflitti intercapitalistici – teoria poi travolta a partire dall’invasione dell’Afghanistan e dall’acutizzarsi clamoroso di tali conflitti – , nonché da altre similari largamente diffuse nella prima fase del movimento italiano no-global, quando si sosteneva che la politica mondiale era diretta da organi transnazionali come il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, il WTO ecc..e il potere statuale era in via di estinzione.
Qui però l’ipotesi di un sistema bancario unificato, avanzata proprio mentre esplodeva un feroce conflitto tra i capitalismi “forti” e “deboli” europei ed ogni banca o sistema finanziario con cuore e cervello nazionali (anche se con membra disseminate nel mondo) lottava strenuamente con i concorrenti delle altre nazioni, è davvero insostenibile: così come la presunta sparizione dei poteri statuali e governativi politici, quando poi è, con tutta evidenza quotidiana, lo Stato tedesco e il suo governo a bloccare qualsiasi tentativo di fermare il tracollo dell’euro e del sistema monetario europeo, con la Bundesbank (la Banca centrale tedesca) che tiene sotto tutela quella che dovrebbe essere la mitica fonte del moderno potere europeo, cioè la BCE. Per non parlare dell’altra tesi dei teorizzatori del “governo unico” e cioè la convinzione che, essendo quello di Monti (a differenza di Berlusconi) il governo dei mercati, della BCE, delle banche e dei finanzieri mondiali, la sua politica “lacrime e sangue” avrebbe ricevuto il plauso di questi soggetti con la conseguenza di un vistoso premio all’Italia sui mercati finanziari del globo: tesi clamorosamente smentita proprio dai suddetti “mercati” (o più precisamente dagli investitori e speculatori finanziari) che, fregandosene dei suoi orientamenti spietatamente iper-liberisti, stanno trattando Monti esattamente come Berlusconi; cosicché lo spread tra Italia e Germania si è oramai assestato sugli stessi altissimi livelli raggiunti durante l’ultima fase del governo Berlusconi, malgrado i pesantissimi tagli governativi ai salari, alle pensioni e ai servizi sociali.
In realtà la fonte della crisi che dal 2008 sta impoverendo i salariati, i settori popolari e vasti strati di ceti medi in Italia, Europa, Stati Uniti e paesi sviluppati non è certo il dilagare del capitale finanziario e bancario che avrebbe messo all’angolo il capitale “produttivo” privato e gli Stati malgrado l’enorme capitale nazionale a disposizione di questi ultimi (di quelli più potenti, ovviamente): e non è crisi in primis finanziaria quanto strutturale e globale dell’accumulazione capitalistica, della produzione e della distribuzione. Si tratta di un profondo sconvolgimento originato all’interno del capitalismo occidentale, che nell’ultimo decennio è andato perdendola sua egemonia universalee la possibilità indisturbata di saccheggiare le ricchezzedel restante mondo senza ostacoli. Le ragioni sono molteplici ma proverò ad elencarne le fondamentali.
1) Quella che molti chiamano la rivoluzione informatica, e altri la terza rivoluzione industriale, ha provocato la più sconvolgente trasformazione produttiva della storia, elevando indicibilmente, grazie ad un’infinita gamma di macchine telematiche impensabili fino alla metà del secolo scorso, la produttività tecnologica, a ritmi che continuano a crescere a velocità supersonica. Negli stessi tempi e con lo stesso personale la produzione è andata decuplicando le sue potenzialità e migliaia di lavori sono scomparsi portandosi dietro decine di milioni di persone in tutto il mondo. Ma a differenza delle precedenti due rivoluzioni industriali non solo quest’ultima non ha offerto ai disoccupati la possibilità di trovare lavoro altrove – e di conseguenza all’aumento incessante della
produttività non fa seguito alcun aumento del consumo, anzi si assiste ad una diminuzione media, nell’Occidente capitalistico sviluppato – ma continua l’accelerazione tecnologica e la sostituzione dei lavoratori/trici con le macchine: al punto che due autorevoli ricercatori del MIT di Boston, Eric Brynjolfsson e Andrew McAfee, dopo aver ricordato che l’economia USA nei primi dieci anni di questo secolo non ha aggiunto neanche un posto di lavoro in più al numero totale già esistente (e dunque perdendone assai in percentuale), calcolano che almeno 50 milioni di posti di lavoro statunitensi (il 40% del totale degli attuali occupati negli USA) potranno essere sostituiti dall’informatica nei prossimi dieci anni.
2) Durante tutto il dopoguerra, fino alla caduta del Muro di Berlino e al conseguente crollo del “socialismo reale” in Europa, la propaganda ideologica capitalistica ha sempre sostenuto che il vero ostacolo all’estensione del benessere prodotto dal Mercato e dalla Concorrenza erano i paesi del blocco sovietico con le loro propaggini nei vari continenti extraeuropei. Ma la sparizione dei regimi “comunisti” non ha prodotto affatto l’ingresso nel mercato mondiale della maggioranza degli abitanti del globo: anzi, almeno i due terzi degli uomini e delle donne nel mondo restano fuori da ogni possibilità di ricevere una significativa quota della ricchezza planetaria. Per giunta, anche i mercati ricchi del Primo mondo sono andati intasandosi di merci e i compratori sono andati riducendosi anche nelle zone più benestanti, con un impoverimento generalizzato pure delle classi medie. Cosicché, unendosi agli effetti dell’enorme incremento di produttività grazie alle nuove tecnologie, il sistema capitalistico occidentale ha dovuto fronteggiare una significativa crisi da sovrapproduzione (o sottoconsumo). Poiché si produce molto di più in meno tempo e con meno forza-lavoro, il conseguente indebolimento del potere contrattuale dei lavoratori, l’aumento della disoccupazione tecnologica e della precarizzazione del lavoro, l’aggressività del capitalismo privato occidentale alla ricerca spasmodica di tassi adeguati di profitto, hanno fatto sì che la produttività del lavoro sia cresciuta molto più dei salari, provocando un aggravamento della crisi da sovrapproduzione percarenza di domanda. L’eccesso di capacità produttiva ha spinto il capitale a cercare nuovi settori da mercificare nei servizi pubblici e nei Beni comuni, a partire da istruzione, sanità, previdenza, acqua, trasporti, energia, cercando di smantellarne il carattere pubblico e qualificato per gettarli sul mercato: ma la mercificazione, provocando un taglio di salario sociale, ha inasprito la crisi, riducendo ulteriormente la richiesta di merci non primarie.
3) Ad aggravare ulteriormente gli effetti dei due processi fin qui esposti, l’ultimo decennio ha registrato l’incedere di un vistoso processo di forte autonomizzazione e di recupero delle proprie ricchezze e della gestione del capitale “pubblico” statale da parte di un numero rilevante di paesi – dalla Cina all’India, dal Brasile al Sud Africa, da numerosi paesi a governo progressista dell’America Latina ad altri dell’Estremo Oriente e in qualche caso pure dell’Africa – e la crescita poderosa di nuove economie che, oltre a produrre a buon mercato, hanno sfondato anche il muro della qualità nelle produzioni più innovative. Il tentativo USA di fermare questo processo con la guerra è fallito: oggi gli Usa non controllano realmente né l’Iraq né l’Afghanistan occupati, né hanno potuto fermare con la forza l’autonomia di gran parte dell’America Latina.
Questi tre fattori congiunti hanno spintoi singoli capitalismi nazionali, di Stato e privati, dell’Occidente (1) a tagliare pesantemente, pur di mantenere un livello di profitti adeguato e reggere la concorrenza con i nuovi capitalismi nazionali rampanti, quella parte di ricchezza che nei momenti migliori del welfare era stata assegnata ai salariati per mantenerne il controllo e limitarne la conflittualità. Ma tale riduzione avrebbe accelerato ulteriormente la sovrapproduzione e il sottoconsumo facendo entrare in una spirale senza uscita il Sistema: cosicché, al fine di cercare di evitare una ulteriore e netta riduzione dei consumi con effetti ancor più depressivi sulle produzioni, nonché la possibile ri-partenza di cicli di lotta sociale intensa, il capitalismo occidentale ha giocato una carta estrema e rischiosa, affidandosi ad una spregiudicata e avventurosaespansione del debito
_________
(1) Non va dimenticato che mentre le condizioni di vita e di lavoro dei salariati, dei settori popolari e di buona parte del piccolo lavoro autonomo e della middle class si riducevano nei paesi del capitalismo storico, esse andavano via via migliorando nei paesi strutturalmente emergenti e in particolare in quelli che stanno incrementando vistosamente le funzioni economiche e sociali dello Stato come gestore del capitale nazionale.
– soprattutto privato negli USA, soprattutto pubblico in Europa – estendendo a dismisura il ruolo del capitale finanziario con la creazione di una gigantesca bolla cartacea, che come effetto collaterale ha certamente potenziato le lobbies della finanza e modificato gli obiettivi delle grandi imprese che al più tradizionale profitto industriale hanno affiancato la massimizzazione del valore di mercato dei titoli, subordinando sovente la logica produttiva a quella della speculazione finanziaria.
Ma l’operazione poteva funzionare solo se, anche grazie al ricorso massiccio alla guerra, l’economia occidentale fosse ripartita con forza e avesse ripreso l’egemonia mondiale oramai agli sgoccioli, nonché il pieno controllo delle risorse energetiche e delle ricchezze naturali come accaduto nel secolo scorso. Non essendo accaduta nessuna delle due cose, il rigonfiamento parossistico della bolla finanziaria non poteva durare oltre: e poiché alla ricchezza virtuale non ha corrisposto un aumento di quella reale, e dato che alla fin fine il capitalismo deve pur sempre affidarsi a beni reali, prodotti e consumati da persone del mondo reale, l’impalcatura di immondizia finanziaria è crollata.
La crisi in Europa e lo scontro tra Stati
Una volta ridimensionata la tesi della finanza come motore della crisi, e accantonato ogni ricorso alla vetusta contrapposizione tra capitale industriale produttivo e capitale finanziario parassitario, descrivere l’esatto posizionamento del ruolo degli Stati – e del conflitto interstatale e intercapitalistico, soprattutto in Europa – è fondamentale per comprendere i passaggi successivi della crisi e in particolare le sue caratteristiche europee e italiane.
“Non è vero che i poteri d’intervento economico degli Stati dei paesi a capitalismo avanzato siano in via d’obsolescenza o di drastico ridimensionamento. Gli Stati capitalistici hanno effettivamente dei limiti d’azione: ma non è vero che siano impotenti di fronte alla cosiddetta globalizzazione dei mercati finanziari e delle merci, o che ne siano vittime. Questa non è altro che l’idea liberale secondo la quale a più mercato corrisponde meno Stato. Al contrario, nonostante la marcata instabilità finanziaria, l’epoca cosiddetta neoliberista ha oramai una durata maggiore della ‘età d’oro’ interventista e keynesiana. Se le banche centrali e i governi dei paesi a capitalismo avanzato fossero stati impotenti a fronte dei ‘mercati globali’, allora la Grande Recessione, o una depressione, sarebbe iniziata nel 1982 o nel 1987, nel 1992, nel 1997 o nel 2001. Il fatto è che i rapporti strutturali tra la sfera economica e quella statale non sono più gli stessi dei primi anni Trenta del secolo scorso. E’ per questo che nel 2008 le economie dei maggiori paesi a capitalismo avanzato non sono entrate in una spirale recessiva simile a quella degli anni 1929-1933. I poteri d’intervento economico e sociale degli Stati capitalistici non sono affatto ridotti ma, nel corso degli ultimi trenta anni, sono stati ridefiniti i termini e le priorità della politica economica e monetaria.
Le regole sono state ridefinite in modo da permettere il flusso finanziario del resto del mondo in direzione degli Stati Uniti, indispensabile per mantenere l’attuale configurazione dell’economia mondiale. I sistemi pensionistici nazionali sono stati riformulati in modo da massimizzare il drenaggio del risparmio dei lavoratori verso il mercato dei capitali. In Europa le politiche di bilancio e la politica monetaria sono state sottoposte a nuove regole al fine di promuovere l’euro come moneta di riserva internazionale, a fianco ma ancora in posizione subordinata al dollaro. Tutto questo sarebbe inconcepibile in assenza di un forte intervento degli Stati dominanti. Le istituzioni finanziarie private e l’innovazione endogena ai mercati finanziari certamente svolgono un grande ruolo. Ma sono le decisioni delle più importanti Banche centrali e gli accordi tra gli Stati dominanti che hanno scandito le grandi linee dell’internazionalizzazione del capitale
monetario. L’unificazione monetaria di gran parte dei Paesi europei ne è la dimostrazione macroscopica” (1).
Se guardiamo la crisi con questi occhiali, le cose diventano assai più chiare, soprattutto per ciò che riguarda la situazione in Europa. Si capisce ad esempio come mai le convergenze tra i capitali di Stato e privati delle principali nazioni europee, che avevano fatto credere che dalla Unione monetaria si arrivasse in tempi ragionevoli ad una Europa unificata sul piano politico e economico, stiano venendo meno. Una volta che – a causa della sovrapproduzione e del sottoconsumo nel mondo occidentale, della riappropriazione delle ricchezze nazionali e della conquista di nuovi mercati da parte dei Paesi dell’ex-Terzo Mondo emergenti, della ridotta possibilità di saccheggiare gran parte del mondo da parte delle tradizionali potenze imperialistiche – la torta a disposizione dell’Occidente e dell’Europa ricca si è ridotta drasticamente, si è aperto un feroce conflitto allamors tua vita mea tra i paesi dell’Unione europea, ognuno dei quali si è impegnato a difendere gli interessi dei capitali nazionali, nel suddetto quadro di riduzione generale del bottino comune.
E tutto ciò mentre nel contempo – anche durante gli ultimi cinque anni di crisi nei paesi del blocco capitalistico dominante – un numero elevato di nazioni emergenti ha migliorato le proprie condizioni, mantenendo costante la crescita economica e la diffusione di un certo benessere tra le classi medio-basse. E a proposito di tali paesi, la gran parte degli esperti economici oramai convengono che la quasi totalità di essi è cresciuta grazie al ruolo centrale del capitale statale, con un neo-keynesismo di tipo nuovo, che, garantendo adeguati tassi di profitto ai capitali privati, ha anche distribuito reddito e servizi sociali a settori di popolazione significativi, allargando il mercato interno e limitando la dipendenza dalle esportazioni e dagli effetti della crisi occidentale (2).
__________
(1) Michele Nobile, Le lezioni della crisi, relazione al Convegno “Dentro la crisi del capitale”, Firenze, 15 dicembre 2011.
(2) Per non far ricorso agli oramai immancabili esempi della “Cindia”, il binomio Cina e India dagli sviluppi record del decennio, basterebbe dare un’occhiata allo straordinario progresso del Brasile nel nuovo secolo, e addirittura proprio nell’ultimo quinquennio. Oltre ad una crescita imponente del PIL, giunta nel 2010 al 7,5% annuo – anche se poi “ridotta” nel 2011 al 2,7% a causa degli effetti collaterali del boom economico e del sovrapprezzamento del real (la moneta brasiliana) penalizzante per le esportazioni – , che l’ha fatta divenire la sesta potenza economica mondiale, il Brasile ha ridotto drasticamente la percentuale di cittadini/e che vivono sotto la soglia della povertà, discesa in sei anni di governo Lula dal 36% del 2004 all’8% del 2010, portando la disoccupazione al 4,7% (meno della metà dell’attuale tasso medio europeo e italiano) e presentandosi oggi, rispetto alla recessione europea, come un’area in espansione, al punto da aver provocato una sorprendente e senza precedenti ondata di immigrazione di lavoro “qualificato” dal Portogallo e dalla Spagna, flagellati dalla crisi. Dalla ex-casa madre portoghese sono partiti verso il Brasile in centomila in due anni e circa 65 mila dalla Spagna nel solo 2011, con una crescita costante di emigrazione del 45% l’anno; mentre dei tre milioni di brasiliani/e che risultavano emigrati ne sono rientrati la metà nell’ultimo biennio. Si tratta per lo più di laureati e professionisti qualificati, attirati dal fatto che, ad esempio, tra rilevanti scoperte di giacimenti petroliferi con conseguenti trivellazioni e vastissime opere infrastrutturali (autostrade, ferrovie, centrali elettriche ecc..), il Brasile investirà 500 miliardi di dollari solo nel prossimo biennio – il doppio dell’intero PIL del Portogallo – e avrà bisogno nei prossimi otto anni di almeno un milione e centomila ingegneri, più del doppio di quanto le università brasiliane riusciranno a formare. Il tutto con un debito pubblico irrisorio rispetto alle medie europee, al punto che i bond del Brasile sono più sicuri (il costo dei credit default swaps, i titoli derivati che garantiscono il rimborso in caso di bancarotta, è più basso) di quelli emessi dagli Stati Uniti, mentre le principali banche brasiliane d’investimento superano oramai in Borsa le capitalizzazioni di potenti imperi finanziari USA come Goldman Sachs e Morgan Stanley.
Il risultato finale di questo processo è sotto i nostri occhi: la riduzione del bottino occidentale complessivo, non compensata più dal mega-bluff finanziario, ha fatto esplodere il conflitto su chi debba pagare tale riduzione. In prima battuta gli Stati europei ed gli USA hanno deciso che fossero i settori popolari a pagare e che banche, gruppi finanziari, grandi industrie e borghesie di Stato e private dovessero essere salvati. Ma tale scelta generalizzata non ha smorzato il conflitto inter-capitalistico tra Stati che è divenuto più profondo, smentendo, speriamo definitivamente, l’assurda vulgata dell’ultimo decennio sugli Stati, inclusi i più potenti, ridotti a cani morti, senza potere, in piena balia dei “mercati” o degli organi transnazionali come il WTO, il FMI, la Banca Mondiale, istituzioni peraltro composte da funzionari delle nazioni più forti, lì collocati dai rispettivi governi per attaccare l’asino dove vogliono gli Stati committenti. La stessa BCE – che, come già detto, alcuni considerano un moloch indipendente dai principali Stati europei, mentre in tutta evidenza il suo personale vi è stato collocato rispettando una rigida alchimia (un manuale Cencelli internazionale) di rapporti di forza tra nazioni – non può fare alcuna mossa che non sia approvata dai più potenti paesi europei e dalla Germania in primo luogo, a partire da quel fondo salva-Stati che resta risicatissimo perché il governo tedesco non è disposto a tirare fuori di più, e dai tanto chiacchierati eurobond, che mai decollano a causa dell’analogo veto germanico.
E altrettanto inconsistente si è rivelata, come già spiegato, la teoria del governo unico delle banche, che richiamava alla mente quell’altrettanto irreale governo unico delle multinazionali che per tanti amici e amiche no-global, prima della guerra USA all’Afghanistan e all’Iraq, sarebbe andato cancellando i poteri degli Stati e dei governi, costruendo un surreale Impero pacificato che avrebbe posto fine a guerre e conflitti interstatali. La competizione/scontro tra le imprese bancarie e finanziarie private degli Stati capitalistici è altrettanto aspra di quella tra le industre e l’idea di una concertazione mondiale tra di esse, che esautorerebbe gli Stati, non ha fondamento: ogni nazione vuole salvare innanzitutto le proprie banche e gruppi finanziari, a dispetto delle interconnessioni che pure esistono tra di essi a livello internazionale. In quanto a rapporti di forza tra banche centrali statali e private, basta comparare i reciproci capitali per rilevare lo stesso rapporto sproporzionato, a favore delle prime, che esiste tra i capitali di Stato e quelli delle industrie private nelle singole nazioni europee, industrie che per giunta molto spesso dipendono dai finanziamenti statali: e ricordare le gigantesche cifre messe in campo dallo Stato USA e in vari paesi europei per salvare banche, gruppi finanziari e assicurativi nel 2008, incomparabilmente superiori ai capitali di tutte le strutture salvate; quali banche private avrebbero potuto sborsare somme del genere?
La verità è che lo scontro politico-economico e inter-statale in Europa è violento e vi si affrontano fondamentalmente due opzioni: a) una è quella di cui si fanno paladini il presunto neo-salvatore della patria italica Mario Monti e il neo-presidente francese Hollande, in base alla quale la crisi va pagata da tutti i settori popolari europei, ivi compresi quelli dei paesi “virtuosi”, perché il prezzo dei default PIIGS, il crollo dell’euro e il ritorno alle monete nazionali ridurrebbero assai anche i profitti dei tedeschi, che avrebbero dunque tutto l’interesse al mantenimento dell’euro; b) l’altra, dominante soprattutto in Germania – lo Stato più forte economicamente, che si è arricchito ulteriormente in questi anni grazie all’euro e ad un mercato europeo (1) verso cui va quasi l’80% delle esportazioni tedesche, e dal quale in gran parte sono finora dipesi tempi e modalità della crisi in Europa – secondo cui la crisi va scaricata tutta sui popoli dei PIIGS preservando i paesi “virtuosi” e la Germania in primo luogo, ove, seppur ridotti in confronto al secolo scorso, restano alti e di qualità, almeno rispetto ai paesi PIIGS, garanzie sociali, salari, pensioni e servizi pubblici.
_
___________
(1) La moneta unica, impedendo agli Stati economicamente più deboli di svalutare la propria divisa
nazionale e dunque di riequilibrare così i rapporti commerciali ed economici con i paesi più forti, ha favorito clamorosamente l’economia tedesca e quella dei suoi satelliti.
Un discreto numero di economisti e commentatori politici sostiene la stupidità dei tedeschi che taglierebbero il ramo su cui sono seduti (il mercato europeo costruito sulla moneta unica) o comunque sottolinea l’anacronismo patologico della loro ossessione storica di fronte ai rischi di inflazione (1). Certamente la politica del governo tedesco di Angela Merkel – che però non viene davvero contrastata dall’opposizione socialdemocratica sul punto cruciale del salvataggio delle economie più deboli nell’area dell’euro e, a tal fine, della indispensabile trasformazione della BCE in qualcosa di simile alla Federal Reserve statunitense, in grado di stampare moneta a volontà e titoli europei per sostenere i paesi in difficoltà e spegnere la speculazione (2) – appare miope e fortemente avventuristica non solo per l’Europa ma per gli stessi tedeschi.
Non va però sottovalutato il fatto che le forze economiche e politiche dominanti in Germania sanno bene che solo una reale e avanzata unificazione economica, fiscale e, inevitabilmente, politica dell’Europa, con abbondante cessione di sovranità da parte degli Stati membri, potrebbe salvare l’euro; e che né la Germania né altri Stati forti intendono rinunciare davvero alla propria sovranità e ai capitali accumulati grazie all’euro, mettendoli a disposizione di tutta l’Europa: e questo anche perché i poteri economici e politici di questi paesi, nella loro maggioranza, valutano assai probabilmente che, nella guerresca competizione apertasi con le nuove potenze mondiali emergenti, quello che considerano il fardello dei paesi a rischio della zona-euro sia troppo oneroso e destini un’Europa così “appesantita” alla sconfitta. Dunque, è molto probabile che la parte maggioritaria della borghesia di Stato e privata tedesca e dei paesi satelliti ritenga spacciato l’euro e pensi che, dopo una fase di turbolenze e di riduzione dei profitti anche a proprio danno, poi potrà ripartire nella competizione intercapitalistica senza la “zavorra” dei PIIGS, confidando molto nella forza dei ___________
(1) Il tracollo economico, dopo la sconfitta nella Prima guerra mondiale, della Germania, la catastrofe della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo sono quasi sempre stati imputati nella pubblicistica tedesca, e non solo, all’inflazione terrificante che divorò l’esperimento di liberaldemocrazia post-bellico. Ma in realtà, come segnalò tempestivamente Keynes, in Le conseguenze economiche della pace, a provocare la disastrosa crisi degli anni ’20 in Germania furono soprattutto le condizioni strangolanti imposte dalle potenze vincitrici al paese sconfitto, tramite le cosiddette “riparazioni di guerra” che esso non era in grado di pagare. Mettendo all’angolo in maniera umiliante un intero popolo, le nazioni vittoriose favorirono e in un certo senso si allevarono in seno il nazismo. Può apparire paradossale che in qualche modo ora la Germania ripeta all’inverso il meccanismo, cercando di mettere con le spalle al muro gran parte dei popoli mediterranei e creando così tutte le condizioni per una crisi catastrofica, sugli esiti politici della quale, per l’Europa e per l’intero sistema capitalistico, nessuno può fare previsioni fondate.
(2) Se la BCE divenisse simile ad una Banca Centrale nazionale, potrebbe ripetere l’operazione fatta negli USA al momento dell’imminente tracollo del sistema bancario e finanziario statunitense, quando appunto la Fed di Greenspan mise a disposizione enormi quantità di dollari per sostenere banche e assicurazioni. Nel caso europeo, sia attraverso titoli di Stato unificati a livello continentale (i cosiddetti eurobond) sia mediante la creazione di grande liquidità monetaria, la BCE imporrebbe un tasso unificato d’interesse – realisticamente una via di mezzo tra quelli tedeschi e quelli dell’area mediterranea a rischio, e dunque, ragionando ad esempio nell’immediato e sui titoli a dieci anni, con tassi intorno al 2.5% o 3% – che spegnerebbe progressivamente la speculazione sui debiti pubblici. Questo però comporterebbe per i paesi forti, e per la Germania in primis, un aumento significativo dei costi dei titoli nazionali, attualmente del tutto azzerati (ibund tedeschi vengono acquistati come bene-rifugio malgrado non diano quasi alcun interesse reale), nonché il costo della conseguente svalutazione dell’euro nei confronti del dollaro e delle altre monete internazionali, che però sarebbe compensato dalla aumentata competitività dei prodotti europei conteggiati sull’euro.
propri apparati produttivi e tecnologici e della propria organizzazione sociale, che dovrebbe consentire su altri mercati extra-europei il recupero delle quote di profitto probabilmente perse nella parte europea travolta dalla crisi.
Quanto di altamente avventurista e a forte rischio ci sia in una tale strategia – che non mette a sufficienza in conto i pericoli, anche per i capitalismi nazionali più forti, di un precipitare irreversibile di una crisi che potrebbe travolgere l’intero sistema occidentale, rafforzando ulteriormente le potenze emergenti che stanno costruendosi gli strumenti per ovviare ad un possibile vistoso calo delle loro esportazioni verso l’Occidente – dovrebbe essere chiaro: pur tuttavia, al momento essa pare che continui ad essere prevalente nella “area forte” europea. In ogni caso l’intero corso della crisi ha messo a nudo l’estrema fragilità e l’improvvisazione avventata e persino cialtrona dell’intera costruzione dell’Unione Europea, basata esclusivamente su un’unificazione monetaria a cui non è seguita alcuna vera integrazione economica, finanziaria, fiscale, politica, legislativa e sociale. Come ha scritto Riccardo Bellofiore:
“L’euro è nato con un vizio di origine. In un’area strutturalmente disomogenea come quella europea, con radicali disparità nella forza produttiva del lavoro e nelle infrastrutture materiali e immateriali, un progetto di convergenza nominale produce un approfondimento della divergenza reale. Quest’ultima può essere attutita solo con una politica fiscale comune. L’asse della dinamica a più velocità del continente europeo è la crescita dell’area ‘forte’ attorno alla Germania. A tirare sono le esportazioni nette e i profitti vengono reinvestiti all’estero. Con l’affermarsi del ‘nuovo capitalismo’ quegli investimenti sono andati però rivolgendosi sempre più alla finanza ‘tossica’, anche a quella interna all’Europa dove i titoli di Stato della ‘periferia’ hanno svolto un ruolo analogo ai subprime negli Stati Uniti. La Germania come i suoi satelliti e il resto del Nord-Europa hanno storicamente bisogno di esportare nel resto d’Europa. I disavanzi commerciali del Sud Europa la aiutano anche perché rendono il cambio nominale dell’euro meno elevato di quanto sarebbe con il marco, o un euro ristretto ai ‘satelliti’. La moneta unica dà inoltre luogo ad una svalutazione reale di cui gode l’area forte”.
Non va dimenticato però che tale clamorosa e quasi assurda contraddizione non è dipesa solo dalla volontà tedesca di recuperare i costi della unificazione del paese dall’intera Europa, approfittando della moneta unica: ma anche, e direi soprattutto, dalla presenza nel nostro continente di capitalismi nazionali profondamente abbarbicati, malgrado le loro ramificazioni globali, nel paese d’origine, quasi sempre divergenti tra loro nelle intenzioni, nei progetti e negli strumenti, che non hanno mai dismesso la forte concorrenza reciproca e mai ragionato non dico su un progetto unitario di una società e collettività europea davvero integrata, ma neanche in termini di capitalismo europeo convergente, al fine almeno di poter meglio competere, sulla base di un gigantesco mercato interno di circa 400 milioni di individui, con le nuove potenze economiche e politiche, le cui dimensioni sono ben altrimenti ponderose di quelle di ogni singolo paese europeo. Come ha affermato Bellofiore (in La crisi globale, l’Europa, l’euro, la Sinistra):
“Inutile prendersela con i ‘mercati’ o con le agenzie di rating. Registrano alla perfezione l’assenza di una qualsiasi regia politica che, sola, potrebbe garantire una via d’uscita. E’ l’impotenza politica che alza progressivamente i tassi di interesse e che rende a rischio di insolvenza un paese dopo l’altro. Le politiche economiche deflattive in tutta Europa aggravano le cose perché abbattono i tassi di crescita. Non ci si può stupire che la sostenibilità del debito pubblico, invece di migliorare, peggiori: se tutti vogliono aumentare la percentuale risparmiata, nessuno ci riuscirà, perché l’agire collettivo abbatte il reddito…La crisi in Europa non è scoppiata per colpa della Grecia. Il colpevole non è stato neanche l’indebitamento pubblico di un particolare paese, nel suo ammontare assoluto o in proporzione al PIL. Quello che Conta è la volontà o meno della Banca
centrale rilevante, qui quella europea, di rifinanziare i disavanzi dello Stato”.
E dunque, poiché dentro la BCE non ci sono altro che i poteri politici e il personale burocratico dei paesi più forti in Europa, e in prima istanza quelli del governo tedesco e della Bundesbak, proprio questi ultimi sono in prima battuta i responsabili del blocco di ogni tentativo di uscita dalla crisi all’interno del sistema dominante, piuttosto che gli indeterminati “mercati” ove ogni agente cerca, capitalisticamente parlando, di portare a casa il massimo profitto per i propri investimenti finanziari. Così come non ha senso sbraitare contro la perdita della cosiddetta sovranità nazionale che sarebbe annullata dal presunto super-potere dell’Unione Europea e sorvolare sul ruolo delle borghesie di Stato nazionali e delle caste dei partiti politici che di fatto posseggono, integrandosi con i centri del capitalismo privato del proprio Paese, la gestione del capitale “pubblico” collettivo di questa o quella nazione.
“Bisogna guardarsi dal considerare i rapporti tra l’Unione Europea e i singoli Stati in termini di mera sottrazione di sovranità ai secondi, non solo perché l’UE è un costrutto degli Stati e non essa stessa uno Stato. Si può vedere nelle politiche della UE e nell’istituzione della BCE non la causa della sottrazione della sovranità ai popoli (e ai governi nazionali) ma, viceversa, l’espressione di un processo politico già affermato al livello dei singoli paesi che viene sviluppato e consolidato su scala internazionale. Così come le differenze tra i diversi capitalismi non sono assorbite nell’unico calderone della presunta globalizzazione economica, allo stesso modo l’UE e la moneta unica non dissolvono le differenze politiche e istituzionali tra i diversi Stati europei. Semmai, creando i meccanismi interstatali che presiedono alla sua diffusione e al suo approfondimento, UE ed eurozona (aree che non coincidono) danno nuovo impulso al processo di chiusura dei sistemi di partito rispetto agli interessi della cittadinanza e di svuotamento delle istituzioni elettive a favore della burocrazia statale, dei vertici della casta politica e di procedure e sedi di mediazione non elettive, che nella dimensione europea sono ancora più opache e distanti da possibili influenze dei movimenti sociali. Le grida indignate per la violazione della sovranità nazionale e la rivendicazione dell’uscita dalla UE e dall’eurosistema mancano il bersaglio confondendo l’effetto con la causa. Non sono l’UE, la troika UE-BCE-FMI, le banche a sottrarre sovranità al popolo: il fenomeno è intrinseco allo Stato capitalistico e in regime liberaldemocratico trova i suoi agenti nel sistema dei partiti nazionali, i sovrani reali, che tanto più sono autoreferenziali quanto più procede l’integrazione nello Stato e l’adattamento alle compatibilità capitalistiche. Quanto alla libertà d’azione dei governi europei, se è vero che è limitata dalla rinuncia ad una moneta nazionale, è anche vero che in definitiva essa dipende dalla posizione dei diversi capitalismi nelle gerarchie della divisione internazionale del lavoro e della potenza statale: con e senza euro, il capitalismo tedesco non è quello greco” (1).
La debolezza dei settori popolari e le manovracce del governo Monti
Purtroppo questo scontro tra Stati e tra cordate capitalistiche nazionali dell’industria e della finanza europea avviene in assenza di un significativo conflitto sociale che costringa le classi proprietarie, “pubbliche” e private, a pagare per una volta loro restituendo almeno una fetta del maltolto, stante che nell’ultimo ventennio, nel Sud Europa e soprattutto in Italia, è stata ridotta vistosamente la quota di ricchezza nazionale destinata al salario diretto e sociale ed aumentatati con assoluta continuità profitti e rendite finanziarie del padronato e delle classi forti. Finora la risposta del lavoro dipendente, dei pensionati, dei giovani e dei settori popolari non è stata, soprattutto in Italia, per nulla adeguata al tremendo prezzo della crisi che ancora una volta sono essi a pagare.
___________
(1) M.Nobile, La gestione politica postdemocratica della crisi economica, in www.utopiarossa.blogspot.com.
I fattori di questa evidente debolezza, almeno per quel che riguarda il nostro paese (ma alcuni punti riguardano la maggioranza dell’Europa), sono molteplici. Volendomi limitare ai principali, direi: a)il controllo delle caste o borghesie di Stato e delle loro strutture di assorbimento della conflittualità, con l’intero sistema politico-istituzionale e degli oligopoli sindacali che, al di là delle scaramucce di facciata e malgrado il sempre più alto tasso di discredito popolare, è apparso anche nel vivo della crisi schierato in modo convergente sulle cose che davvero contano, e in particolare su chi ne dovesse pagare i costi, togliendo così ogni reale speranza di alternative politiche vere; b) la gestione monopolista dell’informazione, che, malgrado lo scontro sulla figura di Berlusconi, in questi anni di crisi ha finito per diffondere un monocorde pensiero unico che ha occultato cause e conseguenze del fallimento del liberismo, oltre ad ignorare o minimizzare qualsiasi lotta o schieramento sociali che fossero estranei o ostili ai due blocchi politici maggioritari; c)la diffusione clientelare di ammortizzatori sociali, individuali, di gruppo o di clan e la forte, e senza paragoni negli altri paesi occidentali significativi, capacità dicompensazione familiare; d) l’economia criminale, più che mai in salute, che, allargandosi ancor più nella crisi, ha assorbito contraddizioni e fatto circolare un ingente quantità di denaro tra vasti settori sociali apparentemente esclusi dalla distribuzione della ricchezza nazionale; e) una convinzione diffusa, grazie anche al quotidiano lavoro del sistema mediatico, tra i settori sociali tartassati, che siamo tutti sulla stessa barca, e che nel conflitto tra Stati ci si deve alleare (e subordinarsi) con i “propri” capitalisti per non far affondare la “barca” comune; f) una sorta di sindrome da Impero romano in decadenza, di fronte alla de-localizzazione produttiva e alle grandi migrazioni, cioè la convinzione che ci sia una comunanza di interessi tra patrizi e plebei contro chi spinge alle porte dell’Europa per partecipare al suo relativo benessere, con il conseguente dilagare di partiti nazi-fascisti, razzisti, xenofobi, e con tanti salariati e settori popolari coinvolti in una terrificante lotta tra penultimi e ultimi, nel timore di essere scavalcati dai migranti nella scala sociale.
Il terremoto produttivo degli anni Ottanta e Novanta, l’incessante sostituzione del lavoro manuale e intellettuale con una pletora di macchine informatiche, le delocalizzazioni verso paesi a infimi salari
e nulle garanzie per il lavoro, lo sgretolarsi delle roccaforti industriali proletarie, la trasmigrazione di campo delle forze politiche e sindacali che avevano organizzato i salariati per decenni, il conseguente venir meno della solidarietà di classe e di ceto, assieme all’incessante lavorio ideologico dei mass media, hanno fortemente indebolito nel lavoro dipendente la coscienza di sé e della propria forza, facendo avanzare l’idea della comunità nazionale come unità con i rispettivi capitalismi nazionali per uscire dalla crisi a spese dei concorrenti degli altri paesi.
E in primis in Italia, negli ultimi anni il leit-motiv unanime di Confindustria, governo Berlusconi, centrosinistra e sindacati confederali è stato quello della difesa del sistema-Italia, del coinvolgimento collettivo – escludente la conflittualità – nella salvaguardia del capitalismo nazionale, “pubblico” e privato. Però, l’acutizzarsi della crisi e il passaggio delle leve di governo nelle mani del governo Monti e dei suoi massacranti provvedimenti sociali ed economici, assommandosi a quelli precedenti berlusconiani, potrebbero modificare questo panorama e permettere la costruzione di una inedita alleanza tra salariati, settori popolari, piccolo lavoro autonomo, o presunto tale, ceti medi impoveriti e senza più solide protezioni.
La manovraccia del dicembre 2011 di un governo più politico che mai – guai a dimenticare che, al di là della demagogia mediatica, Monti conta sull’appoggio dei tre partiti maggiori per i quali in definitiva fa il lavoro sporco ad essi impedito – è stata una pesantissima “patrimoniale” alla rovescia che, invece di essere applicata a chi ha provocato la crisi e ci si è arricchito (quel 10% che possiede più del 50% della ricchezza nazionale), ha colpito duramente quel po’ di redditi e diritti restati a milioni di salariati e di ceti medi impoveriti: massacrate le pensioni, bloccati per anni i salari, aumentata selvaggiamente la tassazione dei beni primari, con un furto globale di decine di migliaia di euro a testa, a danno di chi già da anni stava pagando la crisi. E la successivariforma del lavoro, che avrebbe dovuto aumentare le garanzie a favore del lavoro precario e migliorare i già scadenti – almeno rispetto alla gran parte dei paesi europei forti – ammortizzatori sociali, ha in realtà come obiettivo la ulteriore riduzione di diritti e protezioni sia per gli “stabili” sia per il sempre più vasto universo precario, e per giunta diminuendo ulteriormente i gli “ammortizzatori” nel caso di licenziamenti o disoccupazione cronica.
Pur tuttavia – e contrariamente alle previsioni congiunte sia dei corifei del liberismo montiano sia di chi gli attribuiva il ruolo di longa manus della BCE, dei mercati internazionali e del presunto “governo unico europeo delle banche” – nessuno di questi spietati e unilaterali (nel senso del danno e dei sacrifici) provvedimenti ha minimamente invertito il cammino della speculazione, dello spread, dell’andamento di Borsa e degli esiziali tassi di interessi sul debito pubblico italiano.
La strada scelta sta accentuando vistosamente – come era ampiamente prevedibile – la recessione, a causa della riduzione della spesa pubblica, degli aumenti della pressione fiscale a livelli da record mondiale e dei tagli vistosi ai redditi medio-bassi. Per cui, non solo non vi è stata in questa politica economica alcuna equità ma essa non stimola neanche un minimo di crescita,perché inibisce i consumi e la gran parte delle attività produttive e commerciali, diminuendo conseguentemente gli introiti fiscali e il PIL e quindi mantenendo elevatissimo, per diminuzione del denominatore, il rapporto tra debito pubblico e lo stesso PIL.
Né la distruzione dell’art.18 e la conseguente e ulteriore riduzione dei diritti del lavoro, stabile o precario, comporteranno alcun significativo afflusso di capitali in Italia. Infatti, i ridotti investimenti esteri non dipendono per nulla dal costo del lavoro italiano, che è ben al di sotto della media dei paesi più benestanti d’Europa. Le ragioni sono di tutt’altro segno: a) è assai più sensato investire in paesi ove l’economia continua a tirare e dove si annunciano incrementi di consumo significativi grazie all’ingresso nella capacità di acquisto di milioni di nuovi cittadini, come sta accadendo nelle economie emergenti precedentemente citate; b) spostare le proprie produzioni in un paese in recessione e in pesante crisi come l’Italia è scommessa ad altissimo rischio; c) intere zone del nostro Paese sono in mano alla criminalità organizzata che ne influenza l’economia e i commerci anche laddove non appare dominante; e mettere in conto, oltre ad una delocalizzazione verso l’Italia già complicata per le ragioni prima elencate, anche le tangenti alle varie mafie non è certamente cosa allettante; d) terrorizza infine negli italici apparati non solo la opprimente burocrazia e l’incertezza/aleatorietà delle regole e delle leggi ma ancor più la dilagante corruzione che parte dalla testa delle istituzioni politiche e amministrative nazionali ma che pervade un po’ tutto il territorio, cioè laddove si danno e si tolgono permessi, concessioni, vincoli e costrizioni.
Dunque, non dipende dal destino cinico e baro se, a clamorosa smentita delle capacità salvifiche del governo Monti e malgrado tutti questi pesantissimi provvedimenti fossero in perfetta linea con le tradizionali indicazioni liberiste dell’ultimo decennio, nessuno sconto e nessuna concessione sono stati fatti dai “mercati” a quello che viene considerato da molte parti, in base ai suoi effettivi trascorsi, l’uomo delle Banche, dei mercati, della BCE, del FMI e del governo tedesco. Quest’ultimo, in particolare, non ha favorito Monti in alcun modo, non accettando nulla delle sue pur moderate proposte in materia di carichi collettivi europei dei debiti sovrani; e nulla ha concesso la Banca Centrale tedesca, che ha bloccato finora ogni tentativo di Monti (e di Draghi) di allentare la borsa della BCE, aprendo agli eurobond o alla copertura dei disavanzi statali e bancari più clamorosi, come quello greco e spagnolo (e con quello italiano a seguire).
In barba a chi, da destra e sinistra con toni quasi identici, favoleggiava di “governo unico delle banche”, la politica del governo tedesco ha continuato spietatamente a far ingrassare quelle tedesche, mettendo in conto il massacro di quelle dell’area mediterranea e non solo, abbassando fino ad azzerarlo il tasso di interesse interno e riportando il divario con quelli dell’area mediterranea alle cifre distruttive dell’ultimo periodo di gestione berlusconiana in Italia. E i mercati, che avrebbero dovuto in certe vulgate favorire e sostenere le politiche di Monti, si stanno riconfermando per quel che sono: non già una specie di Spectre che programma centralisticamente l’attacco economico a questo o quello Stato o economia ma una massa multiforme e anarcoide di investitori e speculatori, grandi e piccoli (con in mezzo anche i soldi di centinaia di milioni di salariati, pensionati e ceti medi di tutto il globo, in cerca di qualche profitto o difesa dei propri gruzzoli), a caccia spasmodica della quotidiana scommessa giusta e del guadagno facile e immediato.
Una vasta alleanza sociale anti-crisi
In realtà ci sarebbero altri modi per almeno tamponare la crisi, se tra i capitalismi di Stato e privati europei ci fosse un qualche convergente interesse a salvare la barca, solo apparentemente comune: ed ho già detto quali sarebbero le vie – peraltro ancora tutte interne al meccanismo capitalistico, niente di davvero eversivo – per bloccare la speculazione e raddrizzare la pericolante navicella dell’Unione europea e dell’euro: ma esse richiederebbero, appunto, un’unità di intenti tra i capitalismi nazionali che, almeno per il momento, non si intravede proprio. Per quel che riguarda nello specifico il panorama italico, al fine di far pagare la crisi non a chi paga da sempre ma a chi ne ricava ancor più capitale, rendite e potere, ci vorrebbero una serie di manovre virtuose, che pur non portando ad una fuoriuscita dal sistema, richiederebbero comunque una forte spuntatura dei profitti, dei poteri e delle prerogative del capitalismo privato nostrano e delle fasce ricche della popolazione (quel 10% di italiani/e che detiene più del 50% della ricchezza nazionale), e che ovviamente abbisognerebbe di ben altro governo e soprattutto di ben altro blocco e alleanze sociali e di una elevata mobilitazione popolare per essere sostenuta e imposta.
Tali vie dovrebbero passare per: 1)una vera patrimoniale che, tenendo conto di almeno 5000 miliardi di patrimonio in mano ai più ricchi, anche con una tassa minima dell’1%, fornirebbe circa 50 miliardi annui; 2) il ripristino di una tassazione progressiva sui redditi che incida almeno al 50% sui più alti, con l’inserimento nella base imponibile Irpef di tutti i redditi da capitale e da rendita finanziaria, tassata alle stesse aliquote, sgravando significativamente i redditi più bassi e consentendo così ai salariati, ai pensionati, al piccolo lavoro autonomo e ai ceti medi impoveriti di riequilibrare l’accesso ai beni e ai consumi principali; 3) il recupero di una parte considerevole della gigantesca evasione fiscale, molto probabilmente attestata tra i 300 e i 400 miliardi: stanarne anche solo il 20% garantirebbe un “bottino” pari alle ultime Finanziarie; 4) la drastica riduzione delle spese della politica istituzionale e della corruzione pubblica (strutture amministrative inutili, stipendi della casta da tagliare, benefit e pensioni “d’oro” da eliminare, consulenze principesche e appalti politici “tangentati” da cancellare, corruzione da portare a livelli minimi) che derubano le casse statali per almeno 200 miliardi l’anno; 5) l’abbattimento delle spese militari, dell’acquisto di armamenti e l’eliminazione delle missioni di guerra e delle conseguenti faraoniche spese; 6) il riassorbimento dei capitali dei Fondi pensione nel sistema previdenziale pubblico, per restituire pensioni dignitose a tutti/e.
Sarebbero sufficienti anche solo questi interventi per recuperare cifre colossali, intorno ai 400 miliardi annui, con i quali reinvestire in servizi sociali, Beni comuni, tutela dell’ambiente e salari, introducendo forme di reddito minimo garantito per tutti/e ed elevando così il livello di vita di decine di milioni di persone e la situazione economica generale, facendo pagare finalmente la crisi alle classi, ai ceti e alle caste che l’hanno provocata e che continuano ad usarla per arricchirsi ulteriormente.
Ma naturalmente non è certo un governo della borghesia di Stato e privata italica come quello Monti che poteva prendere in considerazione un tale programma, soprattutto in assenza di una rivolta dei tartassati: e anzi, forte della debolezza delle risposte, ha rincarato la dose con le sedicenti liberalizzazioni. Sbandierando la peraltro reale minaccia del crollo economico, Monti ha prima sostenuto che con qualche farmacia, notaio e taxi in più il PIL italiano avrebbe potuto crescere rapidamente del 10% e i salari del 12%: poi con il suo decreto “liberalizzante” – soprattutto negli articoli 1 e 25 – ha rivelato che nei fatti non di notai, farmacie e taxi si stava parlando, ma della privatizzazione e della mercificazione di tutti i servizi pubblici e sociali locali e dei Beni comuni nazionali, cioè dell’agognato grande business del XXI secolo per il capitalismo: mettere a profitto la scuola e l’Università, l’acqua e i trasporti, la sanità e la raccolta/smaltimento rifiuti, l’energia, il suolo demaniale e i beni ambientali. E in contemporanea a questa selvaggia mercificazione, il governo ha tentato di dare in pasto al grande capitale anche il territorio occupato sempre più a fatica dal piccolo lavoro autonomo, dai contadini e dai pescatori, dai tassisti e dall’autotrasporto più modesto: e da tale punto di vista, la risposta che ha ricevuto, al di là di interventi corporativi e clientelari o para-mafiosi in alcune circostanze, nei giorni di presentazione del decreto sulle “liberalizzazioni”, ha avuto un effetto positivo, perché ha rivelato una forte e decisa resistenza alla penetrazione del grande capitale in luoghi ancora occupati da lavoratori apparentemente autonomi ma di fatto stretti tra mille costrizioni e con redditi medi da settori popolari.
Oltretutto, si è trattato anche di un non trascurabile segnale a quel lavoro dipendente che invece non ha ancora trovato le vie per una efficace ribellione e che dovrebbe nel proprio seno sviluppare anche una riflessione sugli effetti della conflittualità, ingigantita ad arte non solo dal padronato “pubblico” e privato ma anche, assai spesso, dal sindacalismo oligarchico e concertativo, tra i salariati ed il piccolo lavoro nominalmente autonomo. Il terreno più adeguato di una originale alleanza da intentare tra questi settori dovrebbe però essere altrettanto innovativo e prevedere la pratica di una ampia, radicale e non episodicaribellione/rivolta popolare, in grado di usare tutte le armi di lotta con continuità e intelligenza, sostenuta da un vasto fronte sociale, politico e sindacale, che modifichi radicalmente i rapporti di forza e renda realistica l’unica parola d’ordine che finora è risultata unitaria, a livello nazionale ed europeo: “noi la crisi non la paghiamo” e, conseguentemente, “la crisi va pagata da chi l’ha provocata”, imponendo i conseguenti provvedimenti in linea con quanto qui proposto precedentemente.
Proprio all’interno di una rivolta permanente, sia i moti insurrezionali/rivoluzionari del Nord Africa sia, seppure non pagando prezzi altrettanto tragici, i movimenti “indignati” occidentali hanno posto all’ordine del giorno il tema della democrazia integrale e reale e dell’inutilità di aspettarsela da una politica istituzionale ove tra “destra” e “sinistra” opera una sostanziale unicità di programmi e un monopolio di casta che nulla concede alle espressioni democratiche sociali. Smettere di affidare ad improbabili opposizioni di “sinistra/ centrosinistra” la soluzione dei problemi della crisi è oramai un invito che viene da tutte le piazze “indignate” e rivoltose del mondo. Le forme di una democrazia partecipata e diretta, che si contrapponga alle borghesie colluse nel balletto tra destre e sinistre, sono da inventare e sperimentare. E’ decisivo però che nel corso di una crisi che continua ad approfondirsi e aggravarsi, si instauri una vera autonomia politica rispetto alle caste dominanti nelle istituzioni europee, da parte dei movimenti di opposizione sociale e antisistema: e che questi ultimi imparino a lavorare insieme a livello nazionale e internazionale mettendo in campo analisi, iniziative e confronti con il vasto arco di realtà altermondialiste, antiliberiste e anticapitalistiche attualmente in azione, per ricercare ed applicare modelli di democrazia reale, integrale, diretta ed autogestita, inclusiva e non egemonica, plurale e non monocratica.
Piero Bernocchi
6 giugno 2012